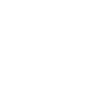Articolo di Gloria Belà del 24/07/2025
UNO SGUARDO AI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE
Quando il cibo parla al posto nostro
Mangiare è un atto quotidiano, apparentemente semplice, ma carico di significati affettivi, simbolici e relazionali. Attraverso il cibo non solo nutriamo il corpo, ma costruiamo il rapporto con noi stessi e con gli altri: impariamo a riconoscere i nostri bisogni, a prenderci cura di noi stessi, a regolare le emozioni. Per questo motivo, il modo in cui ci alimentiamo può diventare uno specchio del nostro equilibrio psicologico.
Ci sono momenti, però, in cui questo equilibrio si incrina. Il corpo smette a essere vissuto non più come una parte integrata del sé, ma come qualcosa da modificare, dominare o punire. Il cibo, allora, smette di essere semplice nutrimento e diventa linguaggio: un modo per esprimere sofferenze interiori, per trovare controllo in mezzo al caos o per mettere a tacere emozioni difficili da riconoscere e comunicare. I Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione non sono solo problemi legati al peso o all’alimentazione in senso stretto: rappresentano spesso la punta dell’iceberg di un disagio più profondo, che coinvolge l’identità, l’autostima, la gestione delle emozioni e il rapporto con l’altro. Per questo è fondamentale adottare uno sguardo clinico che vada oltre il sintomo visibile e sappia accogliere, con rispetto e competenza, la complessità della persona che chiede aiuto.
I principali Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione
Secondo il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione comprendono diverse condizioni diagnostiche che si differenziano per caratteristiche specifiche, modalità di esordio e manifestazioni cliniche:
o L’ anoressia nervosa
L’anoressia, con esordio tipico tra i 15 e i 19 anni, è associata a:
- alterata percezione dell’immagine corporea;
- rifiuto e timore di aumentare di peso;
- condotte di restrizione e perdita di peso attraverso dieta, digiuno o attività fisica, sebbene possano verificarsi anche episodi di abbuffate;
- depressione;
- perfezionismo, dove un maggiore controllo percepito corrisponde a una maggiore sensazione di pace interna;
- bassa autostima;
- difficoltà nelle relazioni interpersonali.
l 5-10% dei pazienti anoressici è di sesso maschile e presenta una sintomatologia più grave rispetto alle donne, con un maggior numero di preoccupazioni relative al cibo, al peso e all’alimentazione in generale, oltre a un più frequente ricorso a sotterfugi per evitare di mangiare. Il pattern alimentare disfunzionale tipico dell’anoressia si caratterizza per una riduzione significativa del numero di pasti quotidiani, con un controllo ossessivo e rigoroso delle calorie e della tipologia di cibo ingerito. Il tempo dedicato al pasto si allunga considerevolmente, poiché il momento della nutrizione diventa un’attività rigidamente controllata e spesso accompagnata da comportamenti ritualizzati. Questi possono includere il taglio del cibo in pezzi molto piccoli, la masticazione prolungata, l’evitamento di determinati alimenti percepiti come “proibiti” o “pericolosi” (come il cioccolato), e pratiche come lavarsi ripetutamente le mani dopo averli toccati. Alcuni pazienti evitano di mangiare in compagnia o in situazioni sociali per non essere osservati o giudicati. Tali comportamenti alimentari e rituali contribuiscono a mantenere e rinforzare la restrizione, agendo come meccanismi di controllo che alimentano la rigidità cognitiva e la difficoltà nella regolazione emotiva tipiche del disturbo.
o Bulimia nervosa;
La bulimia è associata a:
- forte preoccupazione per il peso e l’aspetto fisico;
- mantenimento di un peso generalmente nella norma;
- frequenti abbuffate durante le quali si consuma una quantità di cibo significativamente superiore a quella che la maggior parte delle persone assumerebbe nelle stesse condizioni, con perdita di controllo;
- utilizzo di comportamenti di eliminazione come vomito autoindotto, lassativi o diuretici, o altri comportamenti compensatori inappropriati quali digiuno o esercizio fisico eccessivo per controbilanciare le abbuffate.
o Il Disturbo da alimentazione incontrollata;
Il binge eating disorder, detto anche disturbo da alimentazione incontrollata, è un disturbo alimentare contraddistinto da:
- ricorrenti episodi di abbuffate condotte in solitudine e in assenza di fame, seguite da un profondo senso di colpa e vergogna;
- scarsa autostima e depressione;
- sovrappeso, che a differenza degli obesi comuni, è accompagnato da episodi di abbuffate;
- problematiche psicologiche e fisiche correlate.
o Il Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione non altrimenti specificati
Questa categoria comprende quei disturbi alimentari che provocano un significativo disagio clinico o un deterioramento del funzionamento psicofisico, ma che non soddisfano tutti i criteri diagnostici previsti per i disturbi specifici come anoressia nervosa, bulimia nervosa o disturbo da alimentazione incontrollata.
Tra i disturbi NAS si includono, ad esempio:
-Sindrome da alimentazione notturna, caratterizzata da episodi ricorrenti di assunzione di cibo durante la notte, spesso associati a risvegli notturni e difficoltà a riprendere sonno, senza un aumento dell’appetito durante il giorno;
-Anoressia nervosa atipica, dove sono presenti tutti i criteri dell’anoressia tranne la perdita di peso significativa;
-Bulimia nervosa atipica, con tutti i criteri della bulimia ma con abbuffate meno frequenti; Disturbi dell’alimentazione caratterizzati da comportamenti alimentari disfunzionali che non rientrano nelle categorie classiche, come restrizioni alimentari estreme senza l’alterazione dell’immagine corporea tipica dell’anoressia.
Questi disturbi possono essere altrettanto invalidanti e richiedono un intervento clinico mirato, poiché spesso si associano a gravi rischi per la salute fisica e psicologica.
o La Pica:
Comporta l’ingestione persistente di sostanze non commestibili, come carta, terra, capelli o sapone. Non è legato a pratiche culturali o allo sviluppo tipico e può comportare gravi rischi medici. Compare spesso in età infantile, ma può presentarsi anche in soggetti con disabilità intellettiva.
o Il Disturbo di ruminazione:
è caratterizzato dal ripetuto rigurgito volontario del cibo, che viene poi rimasticato, risputato o ingerito nuovamente. Questo comportamento non è attribuibile a condizioni mediche gastrointestinali e può determinare conseguenze significative, come perdita di peso, malnutrizione e ritiro sociale.
o Il Disturbo da evitamento/restrizione dell’assunzione di cibo:
si tratta di una persistente restrizione nell’assunzione di cibo, che porta a una significativa perdita di peso, ed è motivata principalmente da tre fattori:
1. un apparente disinteresse per il mangiare o per il cibo;
2. un evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali del cibo (come gusto, odore, consistenza);
3. preoccupazioni relative alle possibili conseguenze negative del mangiare.
Come intervenire?
Concludendo, i disturbi alimentari possono comportare gravi conseguenze sia fisiche che psicologiche, come ansia, depressione e isolamento. Tuttavia, è possibile superarli attraverso un percorso terapeutico adeguato. L’approccio cognitivo-comportamentale, supportato da solide evidenze scientifiche, si è dimostrato particolarmente efficace nel trattamento di queste condizioni. L’obiettivo non è soltanto modificare i comportamenti alimentari, ma anche aiutare la persona a riconoscere i pensieri disfunzionali, ristrutturarli in modo più flessibile ed esplorare le emozioni sottostanti, spesso non pienamente consapevoli.
Nel mio lavoro terapeutico, accompagno le persone in un percorso di consapevolezza e cambiamento, con l’obiettivo di aiutarle a ritrovare un sano equilibrio tra mente e corpo, restituendo al cibo il suo significato originario.